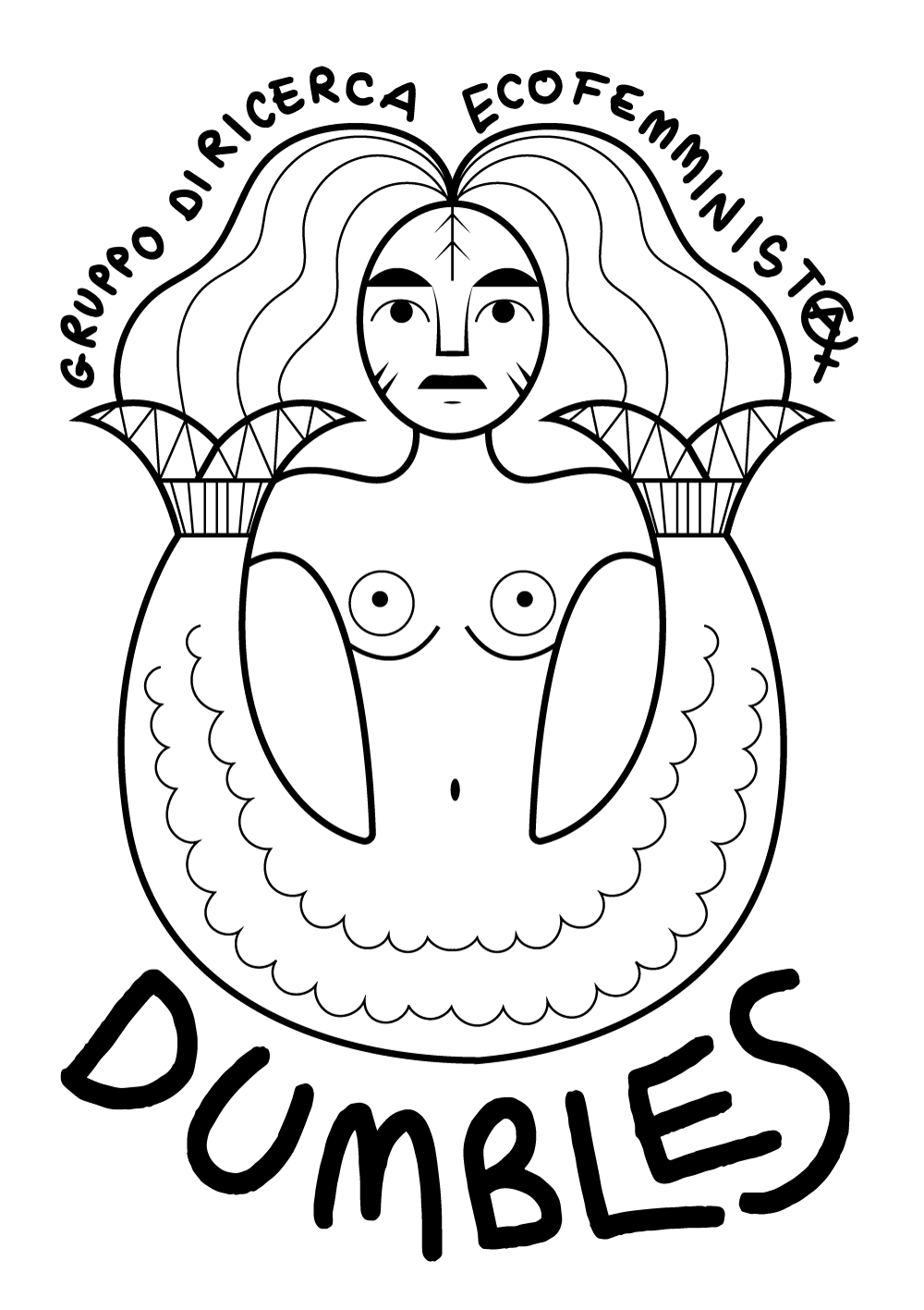Oh, lui Felice!
 La cronaca ricorda l’evento dell’uccisione di Roberta:
La cronaca ricorda l’evento dell’uccisione di Roberta:
GONARS. La uccise a fucilate, infilò il cadavere in un sacco e lo gettò in un cassonetto delle immondizie. Quando, a distanza di qualche giorno, fu ritrovato, triturato in mezzo ai rifiuti della discarica di Firmano, di quel corpo non erano rimasti che i brandelli. La vittima si chiamava Roberta Budai, aveva 31 anni e abitava a Fauglis di Gonars. Il suo carnefice era – e resta – Felice Di Menna, originario di Sulmona (L’Aquila) e, all’epoca, 37enne e sottufficiale al quarto reggimento “Genova Cavalleria” di Palmanova.
Tra i due esisteva una relazione sentimentale. Una storia extraconiugale finita in tragedia nel momento in cui lei, rimasta incinta da lui, regolarmente sposato con un’altra donna, aveva deciso di tenere il bambino. Di fronte al rischio di uno scandalo, Di Menna preferì ucciderla. E fare sparire, insieme all’amante, anche il figlio che stava crescendo nel suo grembo. Succedeva l’8 gennaio del 2001.(MV 29.09.13)
Poi ricorda che lui fu condannato a vent’anni in primo grado e poi in appello ci fu un ulteriore sconto di due anni, infine; la cronaca ci dice che quell’uomo oggi è libero.
Allora ancora non c’era, qui da noi, la parola per quello che oggi definiamo “femminicidio”, ma c’erano e ci sono tutti i sentimenti che vi si rimescolano intorno.
Allora, ci urtò in particolare quella sentenza che fece proprie le attenuanti fondate sull’idea che l’indagato, che pur tanto si preoccupò di far sparire il cadavere avvolgendolo nei sacchi neri della spazzatura, mettendolo nel cassonetto con destinazione la triturazione, che si preoccupò di cancellare le orme lasciate ripassando il suolo con un camion, che congegnò la realtà dei fatti in modo di non essere sospettabile, cioè mentì, che si unì alle ricerche assieme ai famigliari di lei preoccupati per la sua scomparsa…. in realtà non voleva commettere un delitto perfetto ma voleva essere individuato perchè commise una fatale leggerezza: non fece sparire lui direttamente la borsetta di Roberta dimenticata sulla propria auto; nel sacco dei rifiuti, la diede ad un sottoposto perchè la buttasse. Ma quello ci guardò dentro …
Ecco, per il giudice quella defaillance nel piano di depistaggio e menzogna fu una confessione, un pentimento, una ammissione di colpa, perchè, scrisse, in realtà voleva essere scoperto.
Per noi fu la semplice supponenza di chi, sicuro di essere obbedito, si credeva ormai al di là dell’ostacolo.
Quelle attenuanti ci sembrarono allora, e ci sono tutt’ora irritanti e provocatorie non per la riduzione di anni di carcere ma per l’oltraggio alla realtà dei fatti.
E’ la ricostruzione della verità che dovrebbe dare il senso della giustizia, non il conto degli anni di carcere.
Di Menna per un primo periodo fu rinchiuso nel carcere di Tolmezzo; sotto quelle mura, in quest’ultimo anno abbiamo fatto diversi presidi di denuncia in solidarietà con i detenuti e contro il carcere; ne faremo ancora e li faremmo anche se fra i reclusi ci fosse ancora il sudddetto.
Oggi è un uomo libero; che cosa avrà capito di sé stesso e delle sue azioni in questi 14 anni di galera non lo sappiamo, e dubitiamo fortemente che il carcere possa avergli insegnato qualcosa; nello stesso tempo, però sappiamo che non ha capito granchè nemmeno il sistema che lo condannato.
Lui ha ucciso lei perchè lei, incinta, voleva rivelare alla moglie di lui la loro relazione.
Lui era un militare perciò già dentro un nefasto schema di obbedienze e gerarchie; poi c’era la moglie che per obbligo matrimoniale non si deve tradire, poi all’orizzonte si affaccia quello che una volta si sarebbe chiamato “il figlio della colpa”… e come fa uno a mantenersi nel suo universo moralmente ordinato disseminato di sanzioni disciplinari e morali?
O si assume le responsabilità che gli competono e rompe lo schema con tutte le conseguenze oppure elimina la variabile perturbativa.
Lui ha scelto la seconda opzione perchè la prima era troppo faticosa e probabilmente ed anche opportunisticamente percepita come non ammessa.
E’ giustificabile per questo? No, ma una riflessione dovrebbero farla anche tutt* quell* che tanto si prodigano per il consolidamento dello schema-sistema. Perchè quelle attenuanti tanto odiose, si inseriscono lì dentro, dentro quel codice omertoso e solidale fra uomini ma anche fra uomini e donne, dove non si contempla che la parola “responsabilità” sia anche rivendicazione di libertà di amare o relazionarsi con qualcun’altr* anche se si è sotto contratto matrimoniale; non si contempla che “responsabilità” sia anche sfida alle stringenti norme socioculturali, quelle che rendono reale il “rischio dello scandalo” citato dalla cronaca.
Ci vuole ragionamento… e da quando in qua una struttura come l’esercito, fondata sul “signorsì”, sulla gerarchia, sull’obbedienza, è stimolo al ragionamento?
E quando mai, lo è una struttura come il carcere dove il cervello deve funzionare condizionato dal solo esercizio alla sopravvivenza?
Si gira in tondo e non si arriva a nulla.
Si piange la povera Roberta, si depreca il breve periodo di detenzione, ma tutto può continuare e ruotare nello stesso senso.
Punto fermo resta il dolore dei genitori e del fratello che l’hanno perduta; il dolore pietrifica, ma il mondo intorno, dopo il compatimento e la solidarietà dovrebbe trovare lubrificante nel ragionamento che vada all’origine di questi orrendi meccanismi.
Invece si fa la conta delle vittime ora catalogate sotto quella parola “femminicidio” che, inversamente alle intenzioni di chi l’ha proposta, grazie ad opportunistiche giravolte legislative , sta diventando un altro puntello che mette in pace ed a posto la coscienza di tutt*.