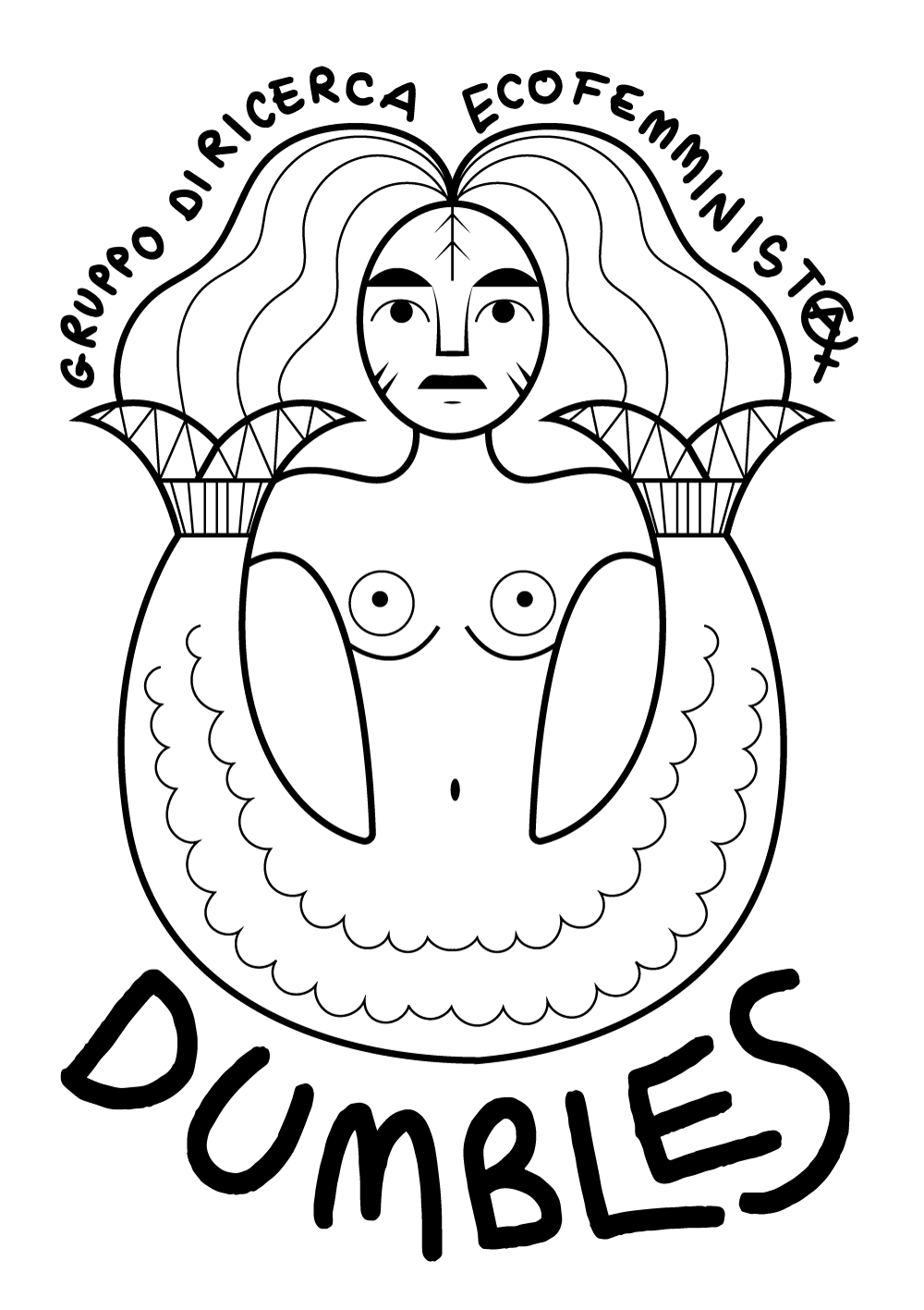I fondamentali
 Non recentissimo ma interessante dialogo intorno alla pandemia fra Sara Campanella ed Elena Gagliasso. Ripresa da qui.
Non recentissimo ma interessante dialogo intorno alla pandemia fra Sara Campanella ed Elena Gagliasso. Ripresa da qui.
Buona e proficua lettura.
Di prospezioni sul futuro se ne parla molto. E a buon diritto: siamo entrati in una nuova fase per Covid-19. Gli scenari filosofici messi in campo da tutto questo, invece, lavorano in sordina, con tempi diversi.
Implicazioni tra ecologia, microbiologia, medicina, impatto antropico, teoria evoluzionistica, esigenze di governances locali e planetarie, sono un banco di prova per la ricerca, per la politica e la psiche umana.
Abbiamo provato a ragionarci su con Elena Gagliasso epistemologa, docente di Filosofia e scienze del vivente della Sapienza Università di Roma.
Lavorando sulla metodologia e sulla storia dell’evoluzionismo, dell’ecologia, sul ruolo delle metafore scientifiche e dei loro contesti socioculturali, Gagliasso da tempo indaga il modo in cui tali ricerche reagiscono su certi criteri demarcativi della filosofia della scienza, come ad esempio la separazione tra le regole del metodo e i valori, tra l’universalità degli invarianti e le unicità individuali.
Alla luce di ciò che sta accadendo – o meglio ri-accadendo – tra umani e virus, è tempo di rimettere a tema, e con urgenza, il discorso scientifico standard e i suoi ampliamenti? Come muoversi (e con efficacia) su tanti piani di incertezze, di bassa prevedibilità, sul collegamento tra scienza e società e come affrontare a livello soggettivo l’‘impensato’ di tutto ciò?
Quanto sta accadendo ci obbliga a riprendere in mano distinzioni classiche che si rivelano ancor più obsolete di quanto gli epistemologi già indicassero anni fa. A farlo ormai con una certa urgenza. Il metodo scientifico che avevamo ereditato dalla scientificità classica era nato per estrapolazione dalle scienze esatte: le leggi del moto dei pianeti della fisica e dell’astronomia: il mondo delle leggi fisse, gli universi ‘della precisione’ per dirla con il grande storico della scienza Koyrè, l’isolamento delle variabili, le loro relazioni misurative, la replica dell’esperimento, la ricerca di nessi causa-effetto lineari. Ecco tutto ciò – e molto altro ancora – costituiva il cuore del metodo scientifico standard e garantiva che la spiegazione coincidesse con la previsione dei fenomeni, che la semplicità e l’eleganza degli algoritmi fosse la spiegazione migliore, garantendo quel Graal costantemente inseguito: la certezza.
Tutto questo impianto era già stato messo da tempo in discussione. Almeno dagli anni ’80 del XX secolo. Ma un conto è discutere in astratto dei problemi epistemologici, delle loro incompletezze, un conto trovarsi sbattuti in una prova di realtà che rappresenta essa stessa un gigantesco test in natura. Un test di cui noi stessi siamo parte in gioco e che concretizza la fragilità delle previsioni e la parzialità dei ragionamenti riduzionistici, che si presenta come un gigantesco ‘acceleratore di interdisciplinarietà’.
Vuoi dire che la scienza delle misurazioni e dell’esperimento ha fatto il suo tempo? Non ti pare un’affermazione al limite?
Voglio dire che va ricontestualizzata: deve unire algoritmo, sperimentazione, modellizzazione con spiegazione narrativa, storica e visione sistemica.
Mettiamola così. C’è bisogno di un potenziamento di misurazioni e sperimentazione. Anzi, quella sorta di espansione di una ‘mente collettiva’, come Ludwik Fleck chiamava il lavoro scientifico, è intensificata oggi dai Big-Data. Ne è splendido esempio Zenodo, l’archivio open-access sul COVID-19 del Cern, progettato dalla sua direttrice Fabiola Giannotti, con la virologa Ilaria Capua. Una potenza di calcolo in tempo reale per l’intera collettività scientifica, ma insieme una straordinaria realizzazione democratica, di cui la scienza riesce ancora a far mostra nella sua fase post-accademica inoltrata.
Quello di cui parlavo è piuttosto un atteggiamento di fondo che integri un orizzonte di pensiero basato su presupposti cognitivi riduzionisti, sulle gerarchie disciplinari, tra hard sciences e scienze dei processi viventi o storia della vita. É l’urgenza di adattare gli strumenti di più metodi e più teorie con bricolages nuovi, ibridando più stili di conoscenza. Mi dirai, Di tutto ciò gli epistemologi in fondo parlavano da tempo, da quando già si ragionava sulle teorie della complessità, o dei sistemi. Ma ora dalle parole si passa alle pratiche e concretamente si ibridano gli stili di ricerca, perché, l’acceleratore di interdisciplinarietà- COVID-19 s’impone come urgenza.
Rimanendo sul piano epistemologico, quale “ibridazione stilistica” va messa a segno in modo più consapevole?
Da due secoli ci accompagna una scissione tra spiegazioni predittive (delle scienze esatte) e narrazione storica (delle scienze umane). Qui, nel nostro caso, da un lato dobbiamo intercettare come e dove agirà il virus e dalle conoscenze sperimentali della sua contagiosità (la sua ‘norma’ infettiva) creare prospezioni: un arcipelago di stime probabilistiche gettate sul futuro, attraverso campionamenti, sperimentazioni, modellizzazioni epidemiologiche, big data, che imbastiscano una preparedness collettiva (Tallacchini).
Dall’altro siamo dentro a una pagina di una grande narrazione della storia evolutiva. Dobbiamo esplorare la storia delle interazioni tra mondi microbici e mondi animali (e quindi umani) fatta di complessità retroattive, casualità random, contingenze fortuite. Ci serve l’indagine ricostruttiva delle tappe passate di questa storia, dei suoi processi lenti o repentini, delle sue latenze, degli eventi unici, dei vincoli che ne conseguono e che delimitano le possibilità per il tempo a venire con cascate di amplificazioni nel lungo periodo. Migrazioni tra specie diverse dei virus, crescita esponenziale della loro biodiversità, effetti delle loro ‘scelte di vita’ attraverso l’infezione delle cellule di organismi animali, ritmi di diffusione delle epidemie e delle pandemie, con i contraccolpi di ciò sulle nostre vicende umane, socio-economiche. Ci serve tutto questo per sapere, per riorientarci, mettendo in sinergia e non in contrappunto il metodo storico di narrazione dei percorsi evolutivi, le quantificazioni degli effetti e le prospezioni. E ciò proprio mentre ci cogliamo plasticamente come parte in causa del processo in atto qui e ora. In modo perturbante e duplice: come ‘vittime’ del contagio e come ‘agenti causali’ delle condizioni ecologiche di fondo che ne hanno permesso l’intensificarsi in frazioni di tempo sempre più vicine: quell’impatto antropico che ha stressato la resilienza degli habitat dove abitano gli ospiti di miliardi di virus, cambiandone i parametri usuali.
Quindi, due storie ci servono, o almeno due lunghezze temporali dovremmo far interagire. Una di breve periodo, contemporanea, e una di lungo, lunghissimo respiro, quello delle ere geologiche e dei primordi di un mondo virale che ora ci riguarda da vicinissimo.
Questa tua osservazione è cruciale. La vicenda, la storia sul breve periodo, ormai in questi mesi abbiamo imparato a conoscerla abbastanza un po’ tutti… È una piccola frazione interna al film della ininterrotta co-evoluzione microbi-specie umana e va colta come sequenza evolutiva: si parte da un certo ‘evento’ puntiforme, spazialmente lontano da qui (una città, anzi un quartiere, di una città della Cina, Wuhan), ma temporalmente vicinissimo: la seconda metà di novembre 2019, come ha potuto ricostruire la dottoressa cinese Ai Fen. L’evento è una mutazione sulle molecole d’attracco della superficie morbida di un coronavirus che viveva endemico tra i pipistrelli selvatici delle caverne e delle foreste. Una mutazione, tra le tante incessanti, che nemmeno si esprimono o che nemmeno possiamo sapere, si rende ‘evolutivamente utilizzabile’ per migrare dall’ambiente interno di una specie classica convivente a quello di una nuova. Il virus ‘tracima’, tras-migra, in altre specie prossime, ‘amplificatrici’ della sua originaria micro-nicchia ecologica e, forse attraverso altri mammiferi ‘ponte’, le si dischiude il vasto interconnesso mondo di 7.7 miliardi di umani. L’ambiente di vita di quella specie di chirotteri (come di molte altre selvatiche) stava mutando. L’espansione dell’urbanizzazione, il consumo di suoli selvatici, la fuoriuscita dei loro abitatori, le decimazioni epidemiche negli immensi allevamenti intensivi locali, l’immissione di sostanze di sintesi che alterano equilibri e temperature dell’atmosfera, mescolano specie di per sé lontane in una promiscuità, che è la vera e propria nuova nicchia ambientale degradata. Intanto, anche l’‘ambiente interno’ dei pipistrelli, con la loro fisiologia iperstressata implicitamente dev’essersi alterato chimicamente e dunque la ‘micro-nicchia’ delle cellule interne in cui il virus ha vita, modificandosi, ha favorito la mutageneticità. Ecco, una frazione di una storia.
E perché non potremmo fermarci qui?
Manca il lungo periodo. Quello che troppo spesso è sottaciuto. L’indagine richiede un metodo indiziario a ritroso, con non poche incognite, anche sul piano categoriale: come classificare i mondi virali? Li vogliamo considerare viventi o non viventi? Come ne monitoriamo la comparsa sul pianeta (dato che non fossilizzano e son molli)? Quante teorie in merito confliggono? Se li consideriamo ‘viventi’ dobbiamo allargare la nozione stessa di ‘vivente’ a chi per vivere non è autonomo, ma ha bisogno di un ospite. Ma se così è, a partire dal mondo virale ci sono ripercussioni sulla categoria stessa di ‘vita’. Quante altre forme, peraltro note di cooperazione, sfruttamento, parassitismo, inserzione prendono nuova evidenza tra specie distanti? Il campo, come vedi, è affascinante e in fermento.
Ma va notato che quello che rivela è semplicemente (anche se non è affatto semplice, ma molto complesso!) il cammino tortuoso e ininterrotto di una storia profondissima che continua. Si riattualizza qui tra noi, oggi, quello che il mondo dei virus, e di molti altri procarioti, ha fatto da sempre, fin dagli albori della vita sul pianeta: evolvere e accrescere la propria biodiversità, ibridando, infettando altri organismi, diversificandosi con essi, creando mosaici di patchwork viventi tra specie, generi e famiglie che solo percettivamente per noi umani sono nettamente separate, ma che la ricerca bioevolutiva ed ecoevolutiva rivela come mondi interconnessi. Un esempio noto? Percettivamente noi stessi ai nostri occhi siamo ‘individui’, ma per le migliaia di cellule batteriche che ospitiamo, e per le inserzioni genomiche dei retrovirus remoti che portiamo nei nostri geni, in realtà noi siamo dei mosaici di diversità biologica, dei ‘micro-biomi’. O, volendo, sul piano filosofico, più che in-dividui, siamo ‘con-dividui’.
Pensi che si potrebbe dire che la storia di lunga durata sta a quella di breve durata come i ‘condividui’ agli ‘individui’? E che l’una senza l’altra è… Parziale?
A pensarci bene, direi di sì. È una affermazione sintetica forte. Cui aggiungere un’attenzione particolare anche al versante dell’ambiente. Anche qui c’è un doppio ruolo: ambienti selettori darwiniani dei viventi e ambienti prodotti dai viventi: del loro stesso esistere come ‘abitatori e consumatori’.
Vuoi dire che siamo anche ambiente?
Certo, siamo ospiti in senso attivo e in passivo: siamo habitat per altre specie viventi che ci trasformano (vedi i simbionti del nostro intestino) e siamo abitatori (spesso trasformatori sconsiderati) dei nostri habitat. Per percepire quanto siamo interconnessi basterebbe guardare le barriere coralline come le vedeva Darwin: non geologia ma prodotto degli esoscheletri dei polipi. Basterebbe guardare come stanno morendo per il nostro inquinamento e l’aumento delle temperature dei mari.
Ecco, ho l’impressione che tutto ciò, l’evoluzione e i suoi meccanismi dispiegati in atto, in tutti i dibattiti e le riflessioni di queste settimane …
Sia stata la grande assente? La scarsa conoscenza dell’evoluzionismo nel tessuto culturale italiano (ma non solo, penso all’America anti-evoluzionista di Trump) ci ha in qualche modo penalizzato?
Penso proprio di sì. Questa assenza ci ha privati di un inquadramento di fondo per accogliere l’impatto di una pandemia prodotta da qualcosa che non puoi percepire. Senza uno sguardo ecoevolutivo non è facile compattare sforzi di governance collettiva, per evitare di vivere persecutoriamente le restrizioni (soprattutto ora, nella cautela del loro rilascio differenziato), per tollerare con conoscenza di causa e in reciproca protezione i distanziamenti tesi a mitigare la diffusione del giovane ceppo virale, esplorativo degli sterminati suoi nuovi potenziali habitat: i nostri corpi. La mancata metabolizzazione dei metodi evoluzionistici non ci ha reso accessibile uno strumento di trascendimento dell’immediato e quindi di collocare l’eccezionalità per noi in una non-eccezionalità per la storia del mondo vivente.
Vorrei tornare però al tuo discorso sul doppio metodo: allora l’esperimento, la certezza e l’esattezza sono, quantomeno, prematuri, se non estranei a questo metodo storico-ricostruttivo?
Separerei questi termini. L’esperimento è essenziale e virologi e clinici sono al lavoro anche grazie a questo cardine basale della ricerca. Spesso diventa indirettamente una corroborazione contemporanea della teoria darwiniana e dunque del suo metodo storico. Un perenne inseguimento segna invece la ricerca di esattezza e certezza nei dati. È un inseguimento che nasce anche da un bisogno di rassicurazione umana, mai così forte come ora. Da un lato ‘la Scienza’, come aspettativa ipostatizzata, viene oggi più che mai pressata dalle richieste sociali ad essere ‘Verbo’ di certezze. Dall’altro, avendo tempi che non appagano le nostre urgenze di azioni risolutive, è oggetto di sospetto. Ogni plot complottistico che presenti una causazione più lineare per la nostra mente (come i virus ingegnerizzati nel laboratorio cinese e rilasciati per errore o volontà) intercetta anche persone colte, ma digiune del ruolo cardine della contingenza nell’evoluzione dei viventi. La cifra della ricerca scientifica consiste proprio nel fatto che non produce certezze incontrovertibili, è autocorrettiva, si deve poter falsificare, e proprio ciò la differenzia dalle ideologie, dai saperi magici, dalle religioni e da tutte le altre forme di rassicurazione umana. Anzi, proprio sull’onda della pandemia, cresce una interessante letteratura sull’epistemologia dell’incertezza, pilastro delle nuove discipline epidemiologiche e della riflessione sulla scienza post-normale (penso all’articolo recentemente apparso di Waltner-Toews et al., e a quello di Bianchi, Cori, Pellizzoni).
Quanto più andiamo sui tempi delle ere profonde della storia dell’evoluzione tanto più l’esattezza è una pretesa frustrante. Qui lo spazio dell’inesattezza, che pur si riduce grazie a forme di datazioni sempre più raffinate, resta peraltro come tensione inesausta nelle ipotesi di molti percorsi remoti e non preclude la possibilità di conoscere.
Credo sia oggi particolarmente importante distinguere le giustificabili ma fuorvianti pretese di certezze e esattezza, dal lento lavorìo della ricerca; fallibile e autocorrettivo, tanto più a fronte di sistemi altamente complessi quali i processi del mondo virale.
Soprattutto per poter in futuro riuscire a collegare gli effetti patologici per noi (il Covid-19) con le cause contingenti della speciazione e migrazione per il mondo di un virus nuovo di zecca (il Sars-CoV-19) i piani dell’esperimento, della ricostruzione indiziaria, dell’incertezza costitutiva si intersecano. Vediamo cose che Darwin, come naturalista, biologo ed ecologo aveva ben chiare: speciazioni nuove (ora in corso sotto ai nostri occhi preoccupati), stabilizzazioni sempre provvisorie (ciò che vediamo come ripetitivo nelle specie a partire dal nostro limitato tempo di vita e diamo scontato come eterno), estinzioni (ciò che ha un andamento che possiamo registrare solo a posteriori, ma che oggi siamo in grado di cogliere in atto, come le sesta estinzione con il crollo della biodiversità, il cambiamento climatico, ecc.): eccolo il palinsesto su cui stiamo giocando questa partita.
Aggiungerei anche con un’urgenza. Quella di riconnettere i due livelli del metodo esplicativo dell’evoluzione: delle cause remote e quello delle cause prossime, per formulare policies adeguate.
Esatto: le ragioni remote dell’origine filogenetica di quest’ultimo virus di una lontana discendenza, difficilmente rintracciabili a ritroso lungo il tempo profondo delle ere geologiche, sono qualcosa di distaccato da noi. Un evento non certo evolutivamente improbabile (che in futuro si ripeterà), ma non determinabile con esattezza, né prevedibile nel suo accadere più vicino. Ovvero, quella causa prossima di un giorno di novembre 2019, in un quartiere di Wuhan, segnata profondamente dalla casualità, sta cambiando il nostro mondo. Avere uno sguardo evoluzionista, ci consentirebbe di connettere i messaggi, spesso recepiti come ‘diverse campane’ delle ricerche dei virologi, delle prospezioni degli epidemiologi, dei tentativi dei medici, in un tessuto coerente. Avrebbe probabilmente reso più responsabili del bene comune primario, della ‘nuda vita’, molti discorsi di importanti filosofi allarmati dalla limitazione delle libertà individuali, intese come espressione di prove generali di forme di regime repressivo. Avremmo potuto dotarci allora – e siamo ancora in tempo per farlo – degli strumenti per capire che si mescolano insieme casualità fortuite con determinismi stratificati e da noi prodotti nello stravolgimento degli ecosistemi. In una circolarità che richiede il criterio della narrazione storica, dell’inseguimento degli eventi, la lettura di panorami sulle dinamiche del tempo profondo assieme alla partecipazione consapevole delle nostre scelte.
Pensarci, percepirci, “in connessione” sembra essere una svolta decisiva non solo per le strategie sociali di contenimento, ma soprattutto per questa presa di coscienza della difficile prevedibilità dei processi coevolutivi. Cosa dovrebbe significare “Convivere in un mondo infetto”, come recita il sottotitolo del visionario libro del 2016 della biologa e filosofa della scienza Donna Haraway, Chthulucene?
Direi che da un lato abbiamo bisogno di nuove “cornici di senso”, un cambio di quei sistemi di premesse con cui si sviluppa il punto di vista sulle cose, in questo caso sull’incontro-scontro virus/umani, spia delle gravi trasformazioni imposte agli ecosistemi selvatici. Dall’altro il riconoscimento che l’impianto di fondo di queste cornici già esiste, fin dalla nascita della teoria dell’evoluzione. Si tratta di riattualizzarle. L’esperienza collettiva in corso che ci attraversa come enti biologici e sociali, sulla nostra pelle, va urgentemente colta in queste cornici, quelle nuove e quella già assodata da tempo. Dici giusto: l’intera materia biologica si conferma ‘in connessione’ con lo stato complessivo del pianeta. La natura agisce dentro la sua propria e la nostra storicità. Insieme ci sovradetermina e noi la influenziamo: siamo infettati e infettiamo mondi. Come dice Haraway, siamo in un’era in cui ereditiamo la distruzione dei ‘rifugi’ per la vita con le conseguenze di ciò e ci è richiesta l’invenzione di nuovi modi d’essere: di co-esistere tra viventi. Apprenderlo in modo diretto, anche attraverso questa dura lezione è, ritengo, un vaccino di igiene mentale.
Sembra quindi che la governance planetaria dei prossimi anni dovrà fare sempre più i conti con questo cambio di prospettiva: l’essere umano come uno degli ultimi luoghi privilegiati di retroazione e mutazione di agenti patogeni ancestrali?
Già. Eppure, a ben pensarci, dal ‘dono fatale del bestiame’ del paleolitico, di cui già parlava Jared Diamond in Armi Acciaio e Malattie nel 1997, l’inesausta drammatica convivenza di tutte le specie eucarioti con virus patogeni è stata il ritmo di fondo della storia. Il terreno di connessione tra la storia della materia vivente tutta e la storia umana, delle sue istituzioni, delle civiltà, delle tecniche, dei rovesciamenti di civiltà. È il ritmo che si è intensificato quanto più ci siamo velocemente interconnessi tra noi (pensiamo all’istantaneità dei vettori aerei in questo caso, vere e proprie ‘iniezioni’ globali del virus sulle radiali del pianeta) e quanto più ci si è mescolati con specie diverse: la cecità espansiva degli allevamenti intensivi come sistema di produzione carnea è strettamente connessa a quanto sta accadendo.
Solo nella frazione di tempo di in poco più di un secolo (un battito di ciglia per l’evoluzione) abbiamo contato un gran numero salti virali di specie che ci hanno riguardato. Dalla influenza Spagnola del 1918-19 con più di 5 milioni di morti alle ondate sempre più ravvicinate di epidemie più o meno locali, ai morti dell’Asiatica del 1957, dell’Aids negli anni ‘70, della Sars, della Mers, dell’ebola, di Zika, Dengue, e molte altre: “l’infezione è uno dei processi fondamentali studiati dagli ecologi, come la predazione, la competizione, la decomposizione e la fotosintesi”, ricordava nel 2012 David Quammen in Spillover, Animal Infections and the Next Human Pandemic.
Ma incredibilmente non riusciamo a renderci conto di convivere con il pericolo devastando l’ambiente, nonostante i migliori epidemiologi europei della prevenzione del rischio, come Paolo Vineis, ne abbiano fatto un manifesto (Carra, Cingolani, Vineis, Prevenire, 2020). Anzi le pandemie, come i disastri ‘naturali’, ricorda la storica Gabriella Gribaudi in La memoria, i traumi, la storia, 2020, proprio perché sembrano poste al di fuori delle intenzionalità umane sono state confinate dagli storici alle scienze dure. Oppure sono oggetto di storie ‘disciplinari’ come la storia dell’igiene sociale o della medicina: negli innumerevoli saggi sulla Grande Guerra, la Spagnola fu considerata (nonostante superasse il numero di morti della guerra stessa) come un ‘effetto collaterale’. Così, quasi tutti i più grandi storici del moderno hanno privilegiato la storia ‘fatta da noi’ e marginalizzato quella ‘da noi subìta’ a causa dei patogeni. Tanto più disinvoltamente sorvolata poi se sterminava selettivamente popoli remoti e ‘ininfluenti’. Una cecità disciplinare che mostra la corda e oggi non ci aiuta.
Forse perché non ci siamo mai davvero percepiti come “ambienti di vita” quali siamo e più come “abitatori (predatori) di ambienti”? Non so, ci sono forse delle ragioni che magari non sono solo riducibili alle miopie disciplinari in questa scelta. Che ne pensi?
Mi fai pensare a un tratto più profondo, a una ‘ferita narcisistica’ che interferisce con il pensiero quando si ‘subisce’ l’infezione degli invisibili virus. Lontani dal padroneggiare la natura, la nostra condizione umana se ne rivela in balìa.
Ti ricorderai, Sigmund Freud in Una difficoltà della psicoanalisi del 1916 aveva scritto delle tre grandi ferite narcisistiche all’onnipotenza dell’uomo inflitte della scienza. Dopo il decentramento terreste newtoniano, era arrivato Darwin con l’evoluzione naturale, con la nostra scandalosa discendenza da antenati comuni animali e, terza, la scoperta della psicoanalisi, il ‘non essere padroni in casa propria’: la razionalità umana sarebbe un sottile strato sulla superficie del profondo mare dell’inconscio.
Ecco, potremmo ipotizzare che la natura delle pandemie saldi in modo vertiginoso le ultime due. È lui, il mondo dei virus, che ha preceduto miliardi di anni la nostra recente comparsa, che ‘comanda’. Noi interveniamo, curiamo con dedizione i nostri simili colpiti, esploriamo meccanismi genetici virali sconosciuti, cerchiamo rimedi e conoscenza. Un po’ a tentoni, per prova ed errore, così come, dal canto suo, sta facendo il nostro sistema immunitario. Ci ‘adeguiamo’ coraggiosamente e con tutti i mezzi disponibili, ma inseguiamo e non dettiamo noi le regole. Certo più ne sapremo, più potremo prevenire gli effetti delle future migrazioni virali, ma le zoonosi restano un tratto costitutivo dell’evoluzione. Ecco questo scacco, che si cerca di colmare dal punto di vista scientifico e clinico, è uno scacco anche della profondità psichica nel nostro orientarci nel mondo noto, che auspichiamo ‘razionale’ e individuo-centrico. Parafrasando, ‘non siamo padroni in casa nostra’ dal punto di vista biologico-evolutivo (e non siamo certo figli di una progressione ascendente) e c’è di più: non siamo nemmeno ente autonomo, individuo ‘singolo’, bensì un microcosmo di milioni di entità che alberghiamo, di cui il nostro corpo è habitat. Questo microcosmo è sede di forze positive per la nostra vita come molti dei nostri simbionti batterici e di forze negative per la nostra sopravvivenza, che si servono di noi per la loro, come i patogeni.
Ma neanche a livello psichico profondo, siamo ‘padroni’, attraversati da sentimenti imprevedibili, da riattivazioni traumatiche governabili a fatica dalla ragione, posti di fronte al groviglio del nostro mondo interiore che questo evento ‘impensato’ disvela.
Patogeni che scatenano una paura oscura ma che ci rimettono al “nostro posto”, si potrebbe dire. Saranno mica un “farmaco”, che per i Greci era veleno ma anche antidoto?
Già… un evento ambivalente. Diciamo: catastrofe e ‘dono’? Questa paura è oscura perché priva di un antagonista intenzionale e percepibile. Per questo ritengo che usare metafore belliche per parlare della pandemia sia fuorviante: non permette nominazioni nuove per ciò che è più perturbante, e l’appiattisce su esperienze note. Tutti i ‘bollettini dal fronte’, l’attivazione muscolare d’odio contro il ‘nemico’, la ‘trincea’ dei medici, come ricorda anche Sanzia Milesi, sono giustificate dalla assonanza con alcuni effetti delle guerre, ma non danno voce al nuovo intrinseco di questa nostra esperienza. E semmai, hanno un risvolto di irreggimentazione.
É anche alla luce di questo scacco, di questa paura dell’invisibile che si può leggere quella forma particolare di inganno, per intenderci la tentazione da fake news del complottismo che dicevo prima. Queste narrazioni ‘canalizzate’ (ce ne furono di speculari, ricordiamolo, per Sars e Ebola) hanno da un lato il ‘pregio’ illusorio della completezza, mentre dall’altro ci riconsegnano il miraggio di un dominio ‘attivo’, un protagonismo, su una vicenda che soggettivamente ci trascende.
Però forse in questo senso il virus è, come tu dici, pharmakon, infatti ci smuove alla responsabilità reciproca: l’altra faccia della pandemia. E quando la vediamo funzionare, nel suo diffondersi solidale, nelle nostre solitudini non isolate, ci affratella. È l’inaspettato ‘dono’ di questa catastrofe. Una responsabilità gli uni per gli altri, che raffrena le nostre libertà individuali per il bene collettivo di tutti nel qui e ora. Ma che ne esige poi un’altra di responsabilità, più vasta, collettiva, che serve al domani: la responsabilità nel progettare forme di vita e di con-vivenza ben diverse da quelle del prima-pandemia, quelle che da tempo un’etica e una politica ambientale ci richiedono. Le stesse che pretendono i Movimenti Fridays for Future delle nuove generazioni, i quali oggi, con minore visibilità pubblica, continuano diffusamente a lavorare proprio in questo momento e proprio su questo frangente. Se è vero che “tre coronavirus in meno di vent’anni sono un campanello d’allarme”, come ricorda Ilaria Capua, allora bisogna che la responsabilità per la cura del futuro si accompagni non con l’agitazione della paura, ma con una ‘trepidazione’ di cura. Cioè, con quell’altra ‘euristica della paura’, di cui già parlava Hans Jonas come di un tratto biologico generatore di prudenza. Occorre che la governance collettiva si trasformi in un’alleanza per la sostenibilità planetaria non più procrastinabile e che le scale dei valori, economici, produttivi e politici vi si modellino sopra. Questo, direi, è il cerchio più vasto di responsabilità intriso di trepidazione e che si affaccia sul tempo del dopo-pandemia.